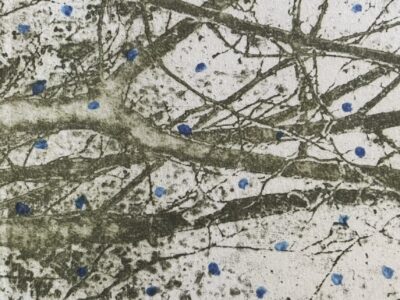Ho trascorso la mia infanzia in un minuscolo centro rurale. Non ho mai praticato il lavoro dei campi come tanti miei coetanei e compagni di scuola meno fortunati di me. Io ero “il figlio del maestro” e questo mi preservava dalla fatica. Ma trascorrendo gran parte del pomeriggio a casa del nonno – un contadino che aveva combattuto la prima guerra mondiale – lo accompagnavo su e giù per il podere curioso dei tanti lavori con cui accudiva quel piccolo pezzo di terra. Stando in quel mondo abbastanza chiuso ero come assorbito dai suoi miti e dai suoi riti intrisi di una religiosità devozionale che investiva in pieno anche me in quanto, tra l’altro, esuberante chierichetto orgoglioso di pronunciare quelle formule latine di cui facevo fatica a capire il significato – almeno fino al Vaticano II -. Mi ponevo, allora, domande assai rudimentali ma, con la frequentazione (universitaria) dei testi demartiniani cominciai a pormi interrogativi più meditati in merito alle ragioni, al senso e ai punti di equilibrio di quella cultura contadina incrociata nella mia infanzia nella quale il fenomeno religioso sembrava scandire il tempo e le stagioni molto di più della natura e del lavoro nei campi. Credo di avere finalmente trovato una risposta autentica, vera, in un autore meno noto di altri al grande pubblico, forse perché frequenta poco le kermesse mediatiche estive pensando, presumo, che il rigore e la serietà della ricerca non hanno continuamente bisogno dei riflettori per essere credibili e imprimere agli studi delle sterzate salutari. L’autore è lo storico Adriano Prosperi con il suo volume Una rivoluzione passiva Chiesa, intellettuali e religione nella storia d’Italia, Einaudi, pp.430, € 34. Anche lui con un’infanzia contadina, anche lui con tante domande (più complesse delle mie) su quella realtà vissuta da piccolo. Riprendendo la categoria gramsciana di “rivoluzione passiva”, a sua volta derivata da Vincenzo Cuoco, Prosperi indaga con precisione la risposta del cattolicesimo romano alla riforma protestante attraverso la cosiddetta Controriforma inaugurata dal Concilio di Trento (1545-1563) fino a esplorare un territorio finora rimosso o poco conosciuto: la nascita di un’altra chiesa rispetto a quella assai poco credibile conosciuta fino ad allora che finirà per prefigurare non tanto una risposta tutta difensiva alla crescita dirompente della Riforma, bensì il radicamento di una religiosità rituale e devozionale che avrebbe concesso ben poco da una parte alle grossolane “licenze” fratesche e dall’altra agli splendori rinascimentali di Giulio II e di Leone X per affermare una forma di controllo (di egemonia?) nei confronti del popolo delle campagne attraverso un nuovo ceto clericale di intellettuali molto ben attrezzati nella “traduzione” delle Sacre Scritture ai poveri contadini. La punta di lancia rivolta al mondo intero di questa “nuova” Chiesa sarà il nuovo, originalissimo, ordine della Compagnia di Gesù (i cui esordi erano già stati trattati in precedenza da Prosperi con il suo volume La vocazione). Ebbene sì, una vera e propria rivoluzione dall’alto – come più tardi sarà, secondo Gramsci, il Risorgimento ma anche il periodo successivo alla prima guerra mondiale – che caratterizzerà nei secoli l’acquiescenza, la passività e la rassegnazione di un popolo incapace – a differenza di altri che avrebbero scosso l’umanità dalle fondamenta con i loro rivolgimenti politici e sociali – di promuovere un vero e proprio cambio di passo attraverso una vera rivoluzione. Una rivoluzione passiva che sbarrerà le porte a qualunque forma di riflessione biblica o teologica in grado di ripensare in modo meno subalterno il rapporto con la propria fede religiosa e con le Sacre Scritture. Il commiato del volume – gli ultimi due saggi dedicati a Erasmo – finiscono così per rappresentare la riflessione amara dell’autore nei confronti di quella grande possibilità rappresentata dalle continue sollecitazioni all’apertura e al confronto elaborate dal religioso olandese spazzate via senza alcuna remora dalla chiesa post-tridentina il cui peso opprimente continuerà a manifestarsi per secoli sugli aneliti di libertà e di emancipazione sociale di un Paese fino a sessant’anni fa prevalentemente agricolo. Un peso che, sottotraccia, finirà per manifestarsi in modo evidente anche in questi tempi un pò tristi. Quelli della cosiddetta “modernità”.