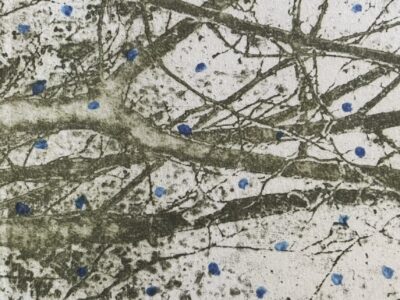C’è una qualità di scrittura nei libri di Paolo Teobaldi, e in questo ancora più esibita che nei precedenti, che è più avvincente delle storie raccontate. Non è, come avveniva per la poesia degli anni ottanta, una parola innamorata, cioè come per quei poeti sedicenti innamorati della parola, ma è una cosa più seria: la cura della lingua. Paolo Teobaldi si prende cura della lingua che usa, e già il verbo usare è un termine inadatto. Fastidioso. Infatti questo autore non usa la lingua, la custodisce, la adopera, ci costruisce qualcosa, come un artigiano. Un artigiano che accarezza i suoi materiali prima di adoperarli, ci passa il palmo della mano, e questo gesto e questo senso, il tatto, sono un segno di affetto e di rispetto, prima del lavoro sulla lingua. Cura della parola significa anche che la parola ha bisogna di cure. E di persone che hanno le competenze e la delicatezza di prendersi cura delle parole, senza altro fine che non sia quello di rimettere in salute i linguaggi, e non di esibire dialetti, neologismi e arcaismi come semplici effetti sonori, residui di una parlata grigia sempre più invasiva e poveramente funzionale. Qui la cura significa saper ascoltare. Non è facile saper ascoltare. Paolo Teobaldi non ha ascoltato soltanto le storie che gli venivano raccontate, ha ascoltato con le antenne sintonizzate le parole con le quali quelle storie venivano trasmesse. Quindi non intendeva documentare soltanto le storie e le persone che altrimenti sarebbero state fagocitate dal silenzio, perché ogni oralità prima o poi si interrompe; Paolo ha conservato il tessuto “fatto a mano” delle storie, riservandosi, come ogni autore vero, il lampo dell’invenzione, dell’ironia, della cucitura sapiente di uno stile.
[vedi anche: Arenaria di Paolo Teobaldi, nel sito]