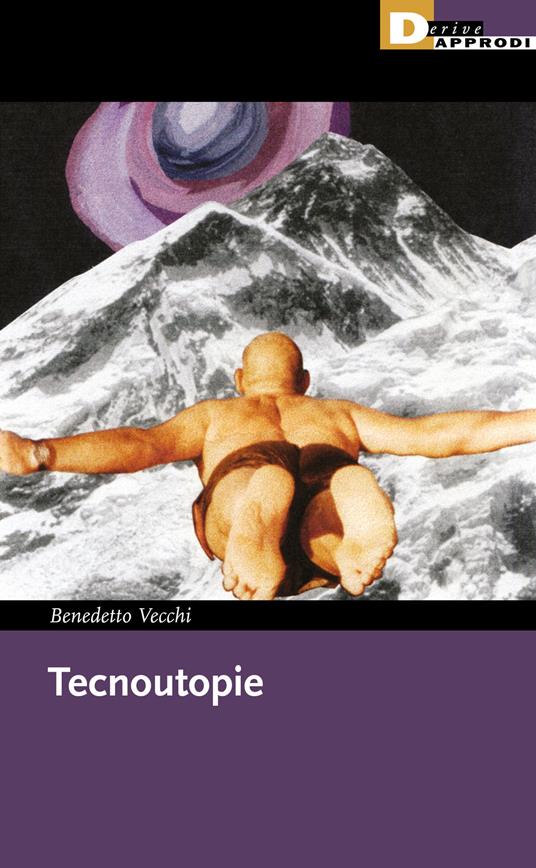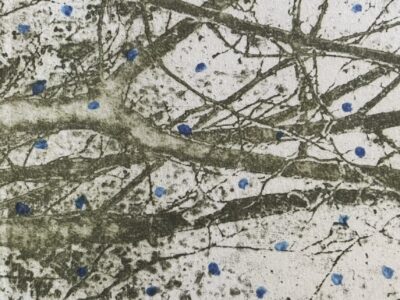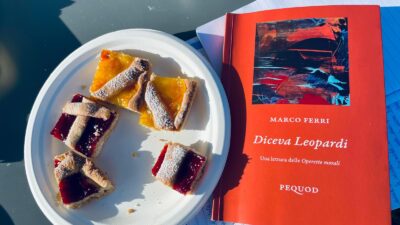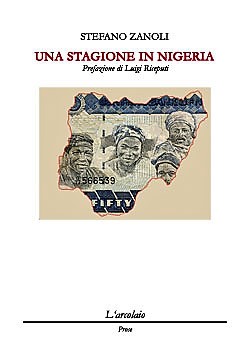La mattina del 6 gennaio 2020 il computer di Benedetto Vecchi era rimasto aperto sul libro a cui stava lavorando da tempo. Solo dopo alcuni giorni sua moglie Laura e sua figlia Marianna avevano deciso di spegnerlo. Benedetto, purtroppo, le aveva lasciate quasi all’improvviso. Ora, grazie al lavoro di Sergio Bianchi e della stessa Laura, è da poco uscito in libreria il testo postumo (e incompiuto) di uno dei più autorevoli studiosi del mondo digitale (e delle nuove tecnologie in genere) che con intelligenza, competenza e passione, anche da responsabile delle pagine culturali de il manifesto, aveva dedicato la sua esistenza, purtroppo interrotta troppo presto, a capire e a farci capire quanto stava accadendo intorno a noi. Tecnoutopie (DeriveApprodi 2022), questo il titolo del volume, pur nella sua dimensione incompiuta, è un testo denso e complesso al punto da farci rimpiangere, oltre alla scomparsa dell’autore, anche quello che poteva essere l’ulteriore sviluppo della sua riflessione.
Volendo trovare una sintesi estrema di questa specie di testamento spirituale di Vecchi potremmo dire che il libro è una denuncia sistematica e documentatissima del vero e proprio sequestro dell’idea di futuro da parte del capitale, un futuro non più progettabile come “atto politico”.
“L’utopia” ci ricorda Vecchi “è sempre un atto concreto, non è un mondo fantastico”; però, nella nostra epoca, ha dovuto fare i conti con quegli “slittamenti semantici progressivi” (cioè con una modifica dei suoi significati), che l’hanno trasfigurata nell’ ”orizzonte di chi il mondo lo vuole conservare così come è, riproducendolo all’infinito e accettando l’innovazione come una sua [continua] riproduzione”.
E’ nella polarità tra “apocalisse” e “catastrofe” che si rivelano questi “slittamenti”: l’egemonia culturale neo-liberale produce tutta una serie di letterature e immaginari “utopici” in cui la catastrofe diventa una dimensione immanente allo sviluppo capitalistico alla fine “rimediabile” con la “buona scienza” per consentire il ritorno al fluire ordinario delle cose. A differenza dell’apocalisse che interviene con modifiche irreversibili che permettono comunque alla vita di continuare anche se in altro modo, diverso rispetto a prima. Di qui il riferimento inevitabile di Vecchi a Ernesto De Martino e alle apocalissi culturali indagate dall’opera – postuma anche quella – La fine del mondo.
“All’ignoto del futuro è preferibile il ritorno del sempre uguale”, questa la spirale rotta dall’illuminismo e definitivamente spazzata via dal “principio speranza” e dall’ ”utopia concreta” di Ernst Bloch anche perché quel ”sempre uguale” si è sempre nascosto dietro la mistificazione di un presunto “disegno divino”: per chi si è azzardato a scostarsi da questo “disegno” il capo d’accusa è stato quello, terribile, di “andare contro natura”.
L’utopista, invece, è colui che ”mette a nudo le potenzialità liberatorie della realtà” dove la scienza cessa di essere un sapere solo “strumentale” per diventare, al pari della filosofia, “una forma di comprensione delle cose umane e della natura”. E, sempre per Bloch, la potenza politica dell’utopia concreta finisce anche per “sbarrare la strada a quel determinismo economicista e a un’ortodossia politica che stava trasformando il socialismo in un Leviatano che avrebbe divorato il movimento comunista”.
Una potenza politica che comunque continua ad agire contro quel cambiamento di significato simile a una nuova plastica facciale, contro quell’utopia conformista, tesa alla salvaguardiae al consolidamento dell’ordine costituito – e non al suo sovvertimento – attraverso l’esaltazione nell’ideologia liberale della solitudine dell’individuo proprietario (Robinson Crusoe) e contro il suo esito “utopico”: quel continuum tra scienza, tecnica e tecnologia in cui le macchine saranno le “leve” per costruire il mondo nuovo, con la tecnica e la tecnologia che diventeranno “le pastorali del presente” dando forma all’incubo di “un mondo a misura di proprietà privata e di macchine al servizio dell’interesse individuale” dove il macigno che sbarrerà la strada all’utopia concreta prenderà il nome di un progresso che confermerà sempre “l’ordine gerarchico presente nelle società”.
Oltre all’eco di Walter Benjamin, è a questo punto che Vecchi finisce per incontrare Antonio Gramsci e la sua categoria critica di “interregno”, a volte impropriamente usata come sinonimo di “transizione” da un regime di accumulazione a un altro simile, sempre all’interno della logica del capitale. Il vecchio sta morendo, il nuovo tarda a nascere e “l’interregno è lo spazio politico, economico e sociale dove si gioca una partita dagli esiti imprevedibili”. Ed è dall’interregno che si svilupperà la categoria-chiave di “rivoluzione passiva” dove, maturata la sconfitta delle forze antagoniste, il potere delle classi dirigenti assumerà contenuti e rivendicazioni delle classi subalterne per sviluppare quei cambiamenti necessari onde mantenere e rafforzare lo status quo.
Un tempo, quello dell’interregno, che nella contemporaneità diventa una “condizione permanente” tesa a occultare che la società del capitale “non riesce a garantire più nessun progresso” nel mentre il futuro diventa – guarda un po’ – il suo campo privilegiato di azione dando forma alla sua ultima rivoluzione passiva: quella, appunto, dell’utopia dell’individuo proprietario. Una tecnoutopia da scardinare, ci ammonisce Vecchi, per dare di nuovo assolutamente forma a una nuova utopia concreta.