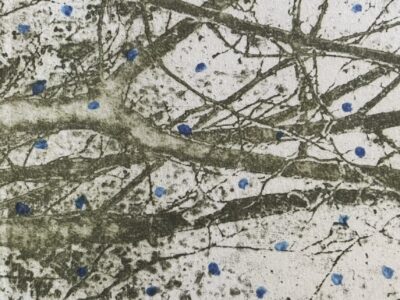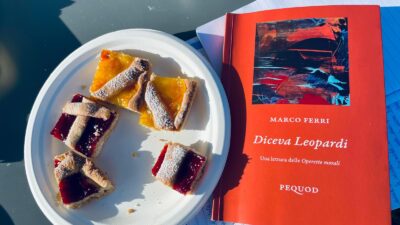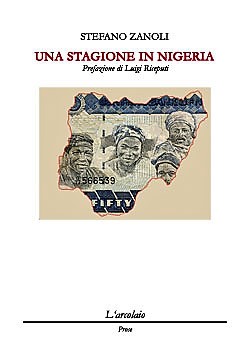Per ricordare Paolo Volponi pubblichiamo un’intervista a Massimo Raffaeli del 25 giugno 2010. Non ha perso nulla della sua attualità.
L‘industria di cui parla Volponi è paragonabile a quella che viene raccontata oggi dai giornali?
Non sono uno studioso di scienze sociali, ma mi viene subito da dire no. Volponi ha vissuto, come dirigente industriale e come scrittore, tutto quanto il ciclo fordista. Va aggiunto che aveva fatta propria, e da subito, l’idea olivettiana del Piano, cioè di uno strumento che non solo redistribuisse i profitti ma sapesse valutare la natura e gli scopi dell’impresa, calcolandone gli effetti in termini di progresso sociale e non di semplice sviluppo economico. Qui Volponi poteva guardare all’altro suo amico e maestro, Pier Paolo Pasolini, ma senza alcuna suggestione retroversa, o nostalgica, perché fermo nella persuasione illuminista che l’industria, specie in Italia, rappresentasse una chance decisiva per il mondo dei produttori, vale a dire la classe operaia. Veniva da una terra di artigiani grandi ma spesso anacronistici, messi fuori dalla produzione in serie, osservava con sgomento i contadini e i fittavoli, nel primo dopoguerra, perché non tollerava di vederli ancora e sempre col cappello in mano di fronte al padrone; accusava la medesima università di Urbino di moltiplicare laureati in belle lettere senza preoccuparsi di allestire, invece, corsi di agraria o di urbanistica. Ma già alla fine degli anni sessanta Volponi aveva intuito sia l’impossibilità di un Piano à la Olivetti (nonostante la sua personale adesione, in questo senso, alla politica del Pci di Berlinguer) sia il sopravvenire dell’onda liberista con la specifica via italiana al post-fordismo. Chi oggi legga Corporale e la favola swiftiana del Pianeta irritabile ovvero il suo grande testamento, Le mosche del capitale, un romanzo che esce alla fine del 1989, coglie in nuce ciò che i venti o trent’anni successivi hanno reso di senso comune. Che la Finanza avrebbe presto metabolizzato l’Industria svincolandola da qualsiasi regola e controllo democratico, Volponi l’aveva testimoniato nella sua opera letteraria, il cui segno epico porta la ricchezza e gli spessori di una grande visione allegorica. Né va dimenticato che, quando Volponi garantiva corpo e voce letteraria alla trasformazione in atto, la parola “globalizzazione” non esisteva ancora.
Premesso che sarebbe opportuno non smarrirne la storia, chi sono oggi i soggetti di un possibile ‘conflitto democratico’ o di lotta per la democrazia nei rapporti di lavoro (e di vita)?
Anche qui vorrei rispondere con la debita cautela, perché ho l’impressione che il discorso perpetuo sui costi e sulle micidiali turbolenze del capitalismo finanziario non distingua abbastanza fra i “globalizzatori”, una élite ristrettissima, e la massa planetaria dei “globalizzati”. Tra questi ultimi si moltiplicano le schiere dei precari e dei non-garantiti, i quali sono anche i più silenziosi proprio perché isolati e quotidianamente ricattati. Qualcosa può venire da lì, specialmente dai più giovani che si dibattono nei problemi di nuda sopravvivenza. Mi ha colpito in questi giorni circa i fatti di Pomigliano, nel pieno rigurgito della dittatura padronale, la lettera che Sergio Bologna (uno studioso molto serio, già attivo nella redazione dei “Quaderni Rossi” di Raniero Panzieri) ha spedito al “manifesto”, dove si leggono queste precise parole: Ma dove cazzo eravate in questi ultimi quindici anni? Davanti ai videogiochi? Non vi siete accorti che il diritto di sciopero non esiste di fatto per più di un milione di precari e lavoratori autonomi da un bel po’ di tempo? Quelle migliaia di giovani laureati che lavorano gratis nei cosiddetti tirocinii, hanno diritto di sciopero, quelli? Messi insieme fanno dieci Pomigliano. C’è un’intera generazione che è cresciuta senza conoscere diritto di sciopero né cassa integrazione, né sussidio di disoccupazione, niente. Fino a quando le persone isolate e ammutolite dal non-lavoro o dal semi-lavoro non sapranno parlare e dunque riconoscere un legame sociale con le tute blu sotto assedio a Pomigliano, ecco, penso che dovremo rassegnarci all’impotenza, alle querimonie che riempiono i nostri piccoli giornali o ai gridi di dolore sterili e persino rituali, oramai, lanciati da qualche più o meno agonizzante trasmissione televisiva.
E la scrittura di Volponi? Esiste oggi un modo così corporale di impastare scrittura e storia?
Non so se è possibile rispondere a una domanda come questa. E’ ovvio che Volponi resta uno dei massimi narratori italiani del secolo scorso e che la sua scrittura è inimitabile, come è ovvio altrettanto che l’Italia di oggi, se non proprio del suo rango, annovera scrittori e poeti di assoluto rilievo. E’ lo spazio ambiente, semmai, ad essere del tutto mutato. Voglio dire che è venuta meno un’idea critica del mondo, prima che della scrittura. Che cos’è il postmodernismo, dove sguazziamo beatamente da vent’anni, se non l’idea che non c’è altrove, che siamo qui, tutti quanti, e perciò non possiamo immaginare altro se non il riuso del già detto, del già scritto? Tale è, per l’appunto, l’infinito catalogo di merci o ready made che va sotto il nome di globalizzazione, un repertorio potenzialmente illimitato ma rigidamente vincolato. Tu puoi dire e scrivere tutto questo ma non altro, così come il telecomando, a disposizione di chiunque, permette una scelta vastissima ma pur sempre all’interno di un menu fisso, intangibile, addirittura tabuizzato. Prima che mancarci Volponi (o, aggiungo io, Pasolini, Fortini, Vittorini, Moravia, Calvino, Sanguineti), ci mancano o ci vengono occultati, perché ritenuti molesti e indesiderabili, gli scrittori che abbiano un’idea critica della realtà come ha più volte ha rilevato, in perfetta solitudine o quasi, lo storico della letteratura Romano Luperini. Cioè coloro che scrivono perché non si rassegnano all’idea che noi viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questo invece proclamava l’ineffabile dottor Pangloss, che pare l’abbia avuta vinta.
[intervista con Marco Ferri, per filobus66, rivista online, 25 giugno 2010]