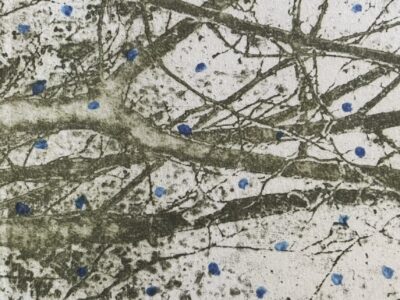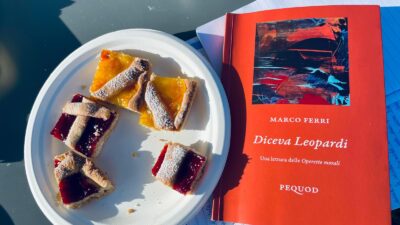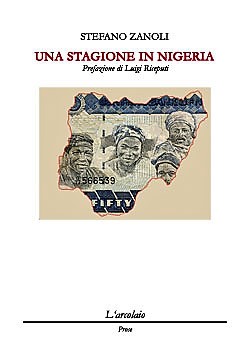Ai tempi in cui frequentavo la vecchia “scuola di formazione politica” – l’Istituto di studi comunisti di Frattocchie, al km. 22 della via Appia – avrei definito, con qualche forzatura, Metamorfosi, l’ultimo volume di Luciano Canfora da qualche giorno in libreria, come un testo “amendoliano”. Per i più giovani che non sanno (quasi) nulla della storia del defunto Partito Comunista Italiano – di cui il 21 gennaio ricorre il centenario della fondazione in occasione del quale esce il volume – Giorgio Amendola era uno dei dirigenti più prestigiosi di quel partito le cui posizioni politiche risultavano a noi giovani “ingraiani” di allora (da Pietro Ingrao, altro dirigente altrettanto prestigioso ma su posizioni opposte) spesso incomprensibili: fedeltà assoluta al “paese-guida”, alla “patria del socialismo” – l’Unione Sovietica – combinata con posizioni sostanzialmente “socialdemocratiche” in politica interna – in particolare sulle questioni sociali ed economiche, con conseguenti, parziali, aperture all’economia di mercato – in base a una lettura quasi “pacificata” della storia del Paese aspramente contestata da due giovani dirigenti, Lucio Magri e Bruno Trentin, in un convegno dell’Istituto Gramsci del 1962. Il volume di Canfora è un testo coraggioso (per qualcuno potrebbe essere anche spregiudicato). In modo schematico la tesi, decisamente controcorrente per i troppi studiosi superficiali di scienza della politica e per i ricordi “nostalgici” dei vecchi militanti, è molto semplice: nel 1944 Palmiro Togliatti “rifonda” un altro partito rispetto a quello nato nel 1921 a Livorno da una scissione dal Partito Socialista. Allora un partito di quadri (per alcuni anche chiuso e settario), di “rivoluzionari di professione”, in funzione – ahimè, in ritardo – dell’auspicata rivoluzione italiana, presenza organizzata in Italia dell’Internazionale comunista di Mosca; ora “il partito nuovo”, un partito di massa aperto alla confluenza di biografie ed esperienze politiche non necessariamente comuniste, impegnato a elaborare una propria “via nazionale al socialismo” e, soprattutto, attrezzato per una presenza articolata nelle nascenti istituzioni (liberal)democratiche alla cui costruzione il partito stava concorrendo insieme alle altre formazioni impegnate nella guerra di liberazione. Ma Canfora non si ferma qui. Con esasperato rigore filologico, com’è suo solito, “pedina” tutto il percorso politico e culturale togliattiano arrivando a una tesi molto ardita: in realtà, mantenendosi in equilibrio con grandissima abilità nelle strettoie della guerra fredda, Togliatti pone gradualmente le fondamenta per un partito “gradualista”, sostanzialmente socialdemocratico e riformatore, integralmente impegnato nelle istituzioni democratiche e ben al riparo dalle suggestioni rivoluzionarie del 1921 – quelle di un Pietro Secchia per intenderci – tese a mantenere una “doppia” struttura – quella dei Comitati di liberazione nazionale – con la quale ipotecare pesantemente la vita istituzionale dell’Italia del dopoguerra. Purtroppo, conclude Canfora, aver abbandonato il grandioso disegno togliattiano è stato fatale. Il disegno di un partito gradualista e riformista, con conseguente approdo alla socialdemocrazia, non sufficientemente perseguito dai suoi successori (in particolare da Enrico Berlinguer) non poteva che portare a un esito finale disastroso: l’inconsistenza culturale (prima ancora che politica) dell’ultimo erede di quella grande tradizione, il Partito Democratico! L’invocazione finale è tutta rivolta alla “resurrezione” della socialdemocrazia europea, in crisi dappertutto come ammette lo stesso Canfora, affinché questa possa riprendere il glorioso (?) cammino del secolo scorso reggendo “la prova della vittoria planetaria del capitale finanziario globale”.

Provo una sensazione contraddittoria di fronte al volume di Canfora, come provavo imbarazzo da giovane con le tesi di Amendola. Da una parte credo che l’originale ricostruzione del percorso togliattiano, anche se indigesta a molti – a “destra” e a “sinistra” – sia ineccepibile perché altrimenti non mi spiegherei la deriva assunta dal dibattito interno per tutti gli anni ‘80 e, se non altro, l’incontenibile entusiasmo con cui gran parte del partito di allora (1989-1991) visse la famosa “svolta della Bolognina” e l’abbandono come ferrovecchio dell’ormai “impresentabile” identità comunista dopo il crollo del muro. Bene o male la trasformazione del PCI in un partito “nazionale”, gradualista e riformista era andata molto avanti e già da decenni il partito non aveva più nulla a che fare con quello del ‘21 e, forse, neanche con il comunismo. Ma dall’altra mi risulta pressoché incomprensibile la riproposizione nuda e cruda (un atto di fede?) dell’approdo socialdemocratico per la sinistra italiana ed europea. Il problema da almeno trent’anni è che la caduta del “modello comunista” ha comportato la contestuale crisi irreversibile del “modello socialdemocratico”, soprattutto nell’Europa occidentale, perché il trionfo liberal-liberista ha costruito un mondo rigido e spietato dove non solo non c’è posto per un modello di sviluppo diverso ma non c’è posto neanche per alcuna forma di (graduale) redistribuzione. Un autore acuto come Canfora dovrebbe aver capito meglio di altri che il capitale finanziario globale è irriformabile e, quindi, non lascia spazio alcuno ai “riformatori” perché non c’è niente da riformare! Credo che realisticamente valga la pena di ricominciare a pensare a rotture ben più radicali, ad un mondo completamente “altro” rispetto a quello para-feudale in cui siamo, anche per responsabilità della sottomissione delle (ex)socialdemocrazie europee al pensiero (e alle politiche) dei vincitori. Magari tornando alle originali e acute riflessioni di Antonio Gramsci, uno degli autori italiani più studiati nel mondo. Un comunista.