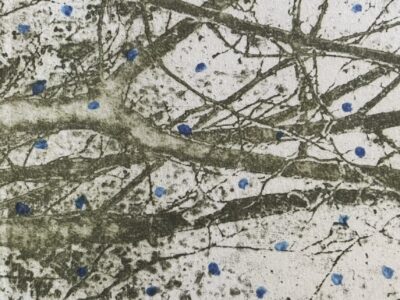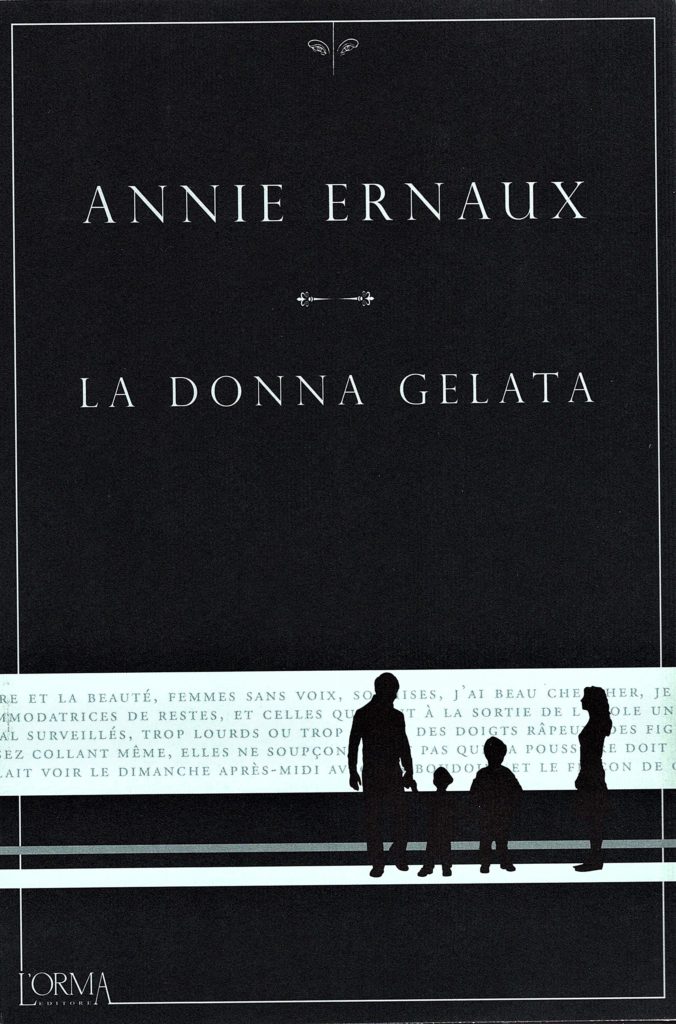
Un equivalente cinematografico di questo libro potrebbe essere un documentario poetico. Il paragone serve solo per orientare il lettore, perché in realtà l’autrice non ritiene corretto assegnare ai suoi libri di narrativa un genere, ad esempio il romanzo, con tutti i suoi sotto-generi. Un’autobiografia? Non basta. Annie Ernaux si definisce “etnologa di sé stessa” e in effetti il racconto cerca di stabilire le tappe di un percorso che è individuale e sociale, soprattutto quello di una donna che vuole capire il proprio posto e il proprio ruolo nella società. Eppure anche questa definizione non mi pare sufficiente. La scrittura diventa saggistica, diario, poesia, ironia, polemica, flusso di coscienza, descrizione minuziosa (epifanica e memoriale), cronaca quotidiana, citazione, ma tutto contribuisce a formare un tessuto cristallino, come un nuovo elemento chimico, di quelli che non rientrano nella tavola degli elementi perché non amano le classificazioni. E poi è soprattutto una ricerca. Nulla di prestabilito, anzi alcune anticipazioni sembrano fatte apposta per negare certe supponenti regole del cosiddetto plot, l’elaborazione del materiale narrativo. Quello che conta è la curiosità di capire. E qui, prima ancora di essere donna, l’autrice è un essere umano che scopre di essere donna e che la donna, stranamente (ma non tanto stranamente quando si colloca dentro una storia culturale, religiosa e politica, segnata anzi marchiata dal patriarcato, dal maschilismo) deve avere dei comportamenti che intralciano o negano del tutto le sue libertà per non intralciare quelle dell’altro sesso. A Rouen come in qualsiasi altro posto della modernissima cultura occidentale. La sensibilità dell’autrice è completamente concentrata su questo aspetto, che potrebbe sembrare a sua volta troppo ideologico ma non lo è, perché il senso delle cose e persino l’uso del linguaggio costruiscono delle mentalità che sembrano naturali ma non lo sono, e soprattutto stabiliscono una condizione femminile subordinata che non è più tollerabile, e questo punto di vista viene prima del racconto e ne stabilisce il percorso, dalle intuizioni infantili su questa condizione, a quelle adolescenziali e giovanili, fino al matrimonio e oltre: è il corpo femminile il luogo fisico e intellettuale delle sensazioni, dei sentimenti e dei ragionamenti: “Non sarò mai così vicina alla libertà sessuale e a una sensualità gloriosa come a diciassette anni. E subito scopro che non mi sono possibili. E’ stata la prima differenza che ho percepito con chiarezza, e mi ha gettata nello sconforto, dubitavo che un giorno si sarebbe mai potuta cancellare. Il desiderio libero è per i maschi, tu no, ragazza mia, resisti, lo dice il codice. E per resistere, la solita strategia difensiva, dividere il mio corpo, dalla testa ai piedi, in territori: le aree disponibili, i campi di manovra dall’accesso incerto, le zone assolutamente vietate. Capitolare un centimetro per volta. Ogni piacere si chiama disfatta per me, vittoria per lui. Vivere la scoperta dell’altro in termini di perdizione, non l’avevo previsto, e non assomigliava affatto a una festa”.
La donna gelata è stato pubblicato in italiano, con la splendida traduzione di Lorenzo Flabbi, da L’orma editore di Roma, agli inizi del 2021, ma si tratta di uno dei primi libri di Annie Ernaux, uscito per Gallimard nel 1981. Con Les armoires vides (Gli armadi vuoti, Rizzoli 1996) del 1974 e Ce qu’ils disent ou rien (Gallimard 1977, non ancora tradotto) costituisce una trilogia autobiografica. Ma cosa è autobiografico e cosa non lo è? Fino a che punto il ricordo appartiene a una biografia soltanto? Una narratrice-ricercatrice come Annie Ernaux, “etnologa di sé stessa”, mentre ripercorre il passato e il proprio passato, insegna a guardare al futuro, e “insegna” credo che sia la parola giusta, sia perché la Ernaux, nata nel 1940, ha insegnato fino al 2000, sia perché il suo tessuto narrativo è cosparso di segni di una poesia limpida e civile, un pensiero poetante (come ha scritto Antonio Prete per Leopardi).