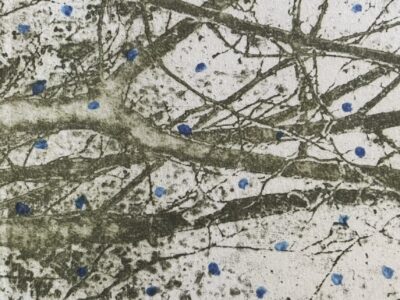C’è una certa allergia, una sedimentata disabitudine, al feeling con un autore. Un autore vero, non un bravo regista. La presunzione ha messo radici: che cosa vorrebbe dirci che non sappiamo già? Meglio iniettarsi una dose di morfina sentimentale o farsi un elettrochoc di terrore e violenza gratuita o fingere di ridere guardando film che vorrebbero far ridere. Comunque: la richiesta (o l’assuefazione) è che i film che si vanno a vedere stiano dentro qualche genere riconoscibile (soprattutto per il consumatore, che vorrebbe che il bugiardino gli anticipasse le emozioni che proverà, acquistando il prodotto).
Ritrovare Nanni Moretti, giustamente invecchiato e poeticamente intelligente, dovrebbe spiazzare un simile pubblico, di solito abituato a dare giudizi e voti, un vizio clericale non solo della critica cinematografica ma della critica in generale, prima che diventasse l’autrice occulta dei bugiardini. Con un film di Nanni Moretti invece si riflette. Probabilmente Il Sol dell’Avvenire non sarà la sua opera migliore, ma è come una sonata per violino e pianoforte, dove i due strumenti vanno in accordo e in disaccordo, si scontrano e si uniscono, soprattutto danno origine a variazioni imprevedibili, o a volte prevedibili, conoscendo l’autore, anzi in qualche modo uno se le aspetta proprio: le sue idiosincrasie ironiche, le sue arguzie, i suoi sguardi che scavano dentro il dramma del personaggio come nell’intimo dello spettatore, e come Moretti rappresenta quello che ognuno di noi fa, da solo, in casa, o con qualche amico, sbottando di rabbia e sconforto di fronte alla banalità dei prodotti commerciali spacciati per capolavori, e come mette a nudo la scarsissima qualità delle scene e delle recitazioni convenzionali a cui ormai non ci opponiamo più. Certo che lo sappiamo, che il cinema è intrattenimento, che lo è diventato e che esclude tutto ciò che non lo è, e che allo stile personale si è sostituita una sorta di cucina internazionale, a volte di buona qualità però spesso anonima, ma è utile ripetere, come fa Moretti anche in questo film, con degli exempla, che non dobbiamo digerire tutto, fa male. Heiner Müller ha detto, più chiaramente: “si ingozzano di merda”. Troppo forte? Forse. Ma nei giudizi degli intellettuali chiamati a testimoniare, Renzo Piano, Corrado Augias e Chiara Valerio, il momento di maggior disperazione coincide stranamente con quello del maggior divertimento: qui penso che stia la cifra poetica di quest’opera. La disperazione crea allucinazioni ma anche la lucidità di una critica sia sociale sia cinematografica. Un intellettuale, un regista, in un universo sempre più frammentato.
Poi c’è la storia. La crisi. Quella privata e quella collettiva: la crisi coniugale del regista Giovanni e la crisi dei militanti comunisti, in una sezione popolare del partito, a Roma, durante la rivolta ungherese del 1956. Avrebbe potuto scegliere il Sessantotto e la rivolta di Praga, ma è andato più indietro, quasi nel primo punto di svolta, e qui le variazioni, come in una sonata di Beethoven, si sovrappongono e si alternano creando una realtà aumentata: Giovanni non si accorge che la moglie non lo sopporta più mentre Silvio Orlando, Ennio, a capo della sezione del PCI, non si accorge che la verità è quella che mostrano le televisioni occidentali e non quella dei titoli dell’Unità (Moretti strappa via Stalin dal manifesto, non lo vuole nel suo film). Più di qualsiasi altra arte, il cinema si basa sulle immagini, su ciò che vediamo, e le neuroscienze ci spiegano che si tratta di allucinazioni controllate ( a volte poco controllate, a volte per niente). Non percepiamo il mondo come è ma come è utile per noi percepirlo (Anil Seth, Come il cervello crea la nostra coscienza). Anche le emozioni sono in fondo delle allucinazioni controllate. E allora la storia si può anche fare con i se. La trama del film diverge dalla realtà storica, come il violino dal pianoforte. Moretti cita anche Italo Calvino quando ha detto che Pavese è morto per dirci che dobbiamo imparare a vivere. Tocca a noi, a ognuno di noi, prendere coscienza che siamo gli attori principali e non le comparse, come vorrebbero farci credere. Ed ecco tutti quei volti dell’ultima scena, in una manifestazione per strada, allegra e irreale, come se fosse possibile, come se fosse vera. Così l’allucinazione finale non è soltanto un Fellini rivisitato, più che altro per la danza collettiva, ma una poesia di Pasolini trasferita in immagine, quella di Alì dagli occhi azzurri: “con le bandiere rosse / di Trotcky al vento”. Un sogno, e molti sorrisi. E comunque l’allucinazione più forte, dopo aver visto quest’opera, è il primo piano del volto di Nanni Moretti che sembra scrutare l’onestà intellettuale dello spettatore.