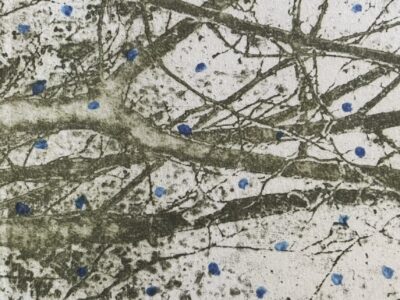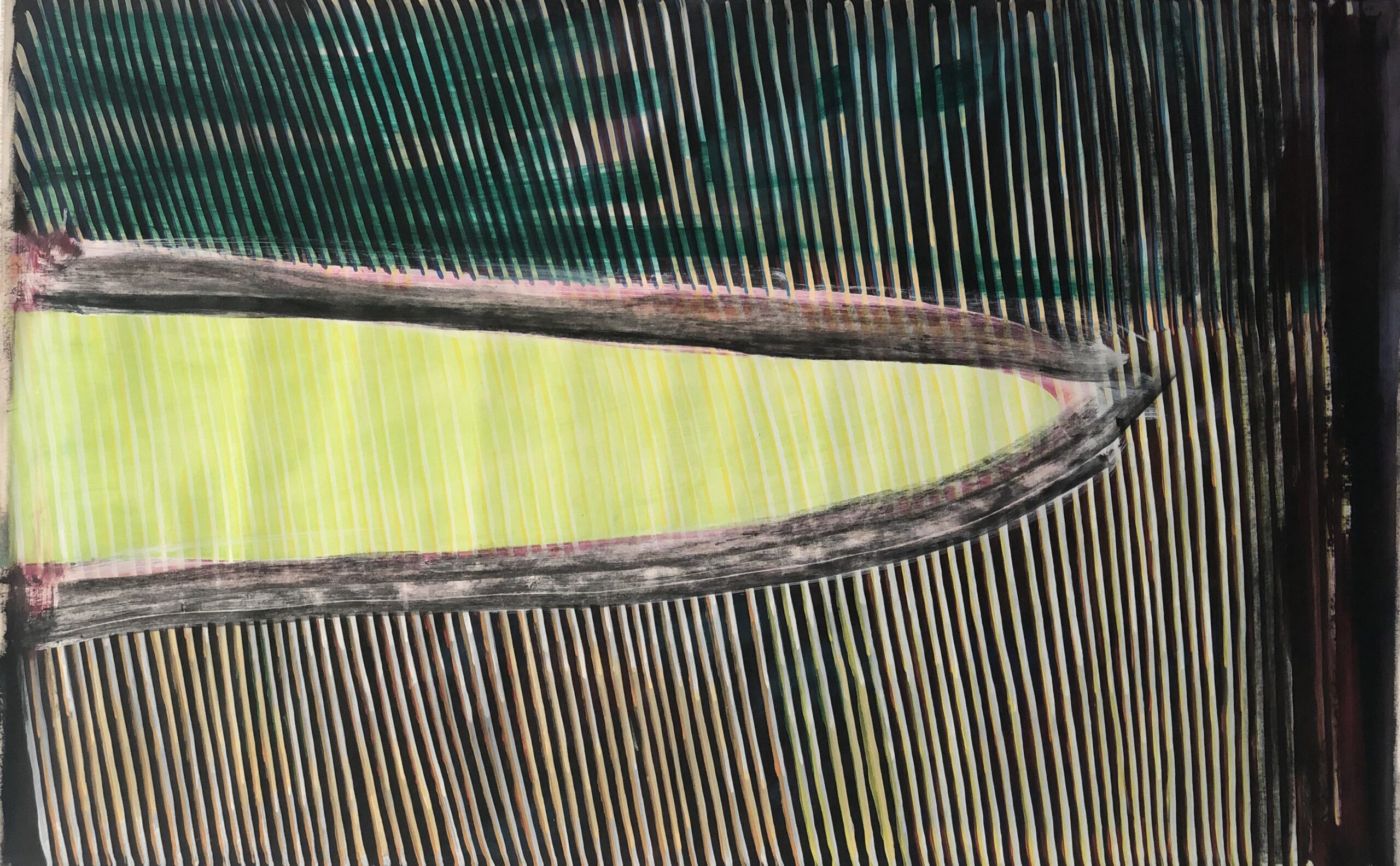[da Viaggio a Budapest di Augusto Brunori]
Fare parte della squadra era un onore, nonostante gli inconvenienti: le botte degli avversari, del proprio papà, la pioggia e il fango, i raffreddori e la tosse. Era sufficiente una piccola mancanza e per punizione niente partita la domenica mattina.
– Così impari e mi risparmi la fatica di lavarti i calzoni e la maglia, ché quando ritorni sembri un porcello.
Ultimo ostacolo, non facile da superare, era il parroco, che non metteva il naso nella formazione ma aveva il diritto di veto verso chi non si era comportato bene al catechismo. Del resto, le maglie, i calzoncini e le scarpe chiodate erano di proprietà della parrocchia.
Anche se la banda si era conquistata un proprio campetto sul quale giocava ogni pomeriggio, l’incontro della domenica era ad un livello più alto. La stessa preparazione era un rito: si preparavano mezz’ora prima nello scalcinato stanzino che fungeva da spogliatoio, ascoltavano in silenzio le spiegazioni dell’allenatore: la tattica da seguire, gli avversari da controllare, le posizioni da tenere in campo. Alla fine venivano distribuite le maglie: non in base ai ruoli ma alle altezze. Così Duccio, che giocava terzino destro, aveva la numero 11 mentre Sauro, ala destra, indossava la maglia numero tre. Nessuno si lamentava: le scarpe a punta di cuoio nero e lucido con i bulloni, i calzoncini bianchi, la maglia rossa con il numero ben stampigliato sulla schiena erano un sogno realizzato. Quando finalmente la porta dello spogliatoio veniva aperta, la luce improvvisa causava un leggero stordimento; preceduti dall’arbitro, un ex pompiere in pensione, i giocatori correvano verso il centro del campo e si allineavano lungo la riga bianca, incoraggiati dalle tribune. Lì, in mezzo ai ragazzi, spiccavano diverse treccine bionde. Una col grembiule a scacchi, in prima fila, sventolava di tanto in tanto un fazzoletto bianco. Duccio sperava che fosse per lui.
Al trentesimo del primo tempo l’arbitro interrompeva il gioco con un fischio secco: la palla finiva di rotolare oltre la riga bianca, senza che nessuno la inseguisse e i giocatori si fermavano esattamente dove si trovavano. Si commemoravano i giocatori del grande Torino, morti sette anni prima per la caduta del loro aereo. Duccio, impettito, rivedeva il filmato della Settimana Incom. “Alle prime luci dell’alba l’immagine che si presentava agli occhi dei soccorritori era agghiacciante : nessun segno di vita dalla carlinga ancora fumante. Tra i resti di un sedile vie è una maglia granata: è l’aereo che riportava a casa la squadra di calcio del Torino da un incontro amichevole in Portogallo”. Duccio, i giocatori li conosceva ad uno ad uno: Bacigalupo, Ballarin Maroso … Menti, Loik, Mazzola …
Aveva appena due anni quel 4 maggio del 1949. Ne sentiva parlare ancora sugli spalti dello stadio, nelle domeniche spazzate dalla bora, quando i tifosi, battendo i piedi, si stringevano l’uno con l’altro sulle tribune popolari. Spesso il malumore per lo spettacolo non esaltante della squadra di casa si stemperava nel ricordo dei campioni scomparsi. Anche nelle stanze fumose dell’osteria si parlava di quei giocatori e l’oste aveva dipinto di rosso la parete dietro il banco, e in alto, sotto il crocifisso, aveva messo una grande fotografia della squadra, con tutti i nomi sotto. L’oste andava ad assistere alla partita dei ragazzi, la domenica mattina. Da giovane era stato un discreto calciatore, forse nella Triestina, in serie A. Si appollaiava lassù, all’estremità delle tribune, e durante il minuto di silenzio si alzava in piedi, si toglieva il largo cappello e se lo portava al cuore; con l’altra mano si toglieva il sigaro spento dalla bocca. Quando l’arbitro fischiava la fine del silenzio, si toglieva il fazzoletto al collo e se lo passava sugli occhi.
Riprese la gara. Duccio, Sauro, Angiolino erano l’ultima leva della squadra, e anche i punti deboli. Angiolino, per le sue dote acrobatiche (sapeva camminare su una corda tesa) era stato messo in porta, dove non riusciva neppure a sfiorare la traversa, ma se fosse cresciuto in proporzione alle tacche tracciate sui pali della porta sarebbe presto riuscito a dondolarsi su quella traversa. Per rimediare, era stato piazzato davanti ad Angiolino un centromediano spilungone e smilzo, con le orecchie a sventola. Comunque Angiolino non temeva le mischie e i rasoterra. Per intimorire gli avversari urlava il grido di battaglia dei commandos giapponesi : Banzai! Inoltre diventava un kamikaze in uscita sugli avversari che si avvicinavano pericolosamente alla porta, poi si rimetteva in piedi e alzava al cielo il pallone catturato.
Duccio invece aveva un compito molto umile: doveva appiccicarsi all’attaccante più insidioso, ma proprio attaccato: gli devi sentire battere il cuore, gli urlava dalla panchina l’allenatore. La cosa non era facile perché il centravanti avversario era sempre un tipo spigoloso che oltre ai piedi usava molto bene ginocchia e gomiti. Gomitate negli zigomi, ginocchiate nei reni, anche ditate negli occhi.
– Può essere anche un dio, ma se gli porti via il pallone diventa un brocco qualsiasi, gli dicevano gli amici.
Duccio veniva regolarmente saltato, tuttavia, con un rapido dietrofront tornava nella linea difensiva, dietro a tutti, pronto a intuire dove sarebbe schizzato il pallone. E non doveva allontanarsi dall’area di rigore, altrimenti sarebbe stato escluso dalla partita successiva, così quel piccolo rettangolo era diventato per Duccio come Fort Apache assediato dagli indiani. Lui conosceva ogni ciuffo d’erba, le buche. Giocava d’astuzia.
Sauro, dei tre, era quello che prometteva di più; si era comprato il manuale del campione e davanti allo specchio di casa, con una palla di stracci, provava finte e controfinte. Giocava sul lato sinistro, come attaccante. Una volta, invece di crossare al centro, si era liberato di un difensore usando una delle finte provate a casa, ma si era beccato una calcione sulla caviglia che l’aveva mandato col muso a terra.
Una volta però aveva recuperato il pallone dalla sua area e aveva calciato la palla avanti, lanciandosi in una cavalcata furiosa. Dietro di lui la muta dei difensori lo rincorreva, se li sentiva alle calcagna come una lepre inseguita dai segugi: “atterralo, atterralo!”. Aveva sentito il rumore dei tacchetti che tentavano di falciarlo, ma ormai vedeva come un miraggio l’area di rigore della Ardor, con il solo nero portiere che inveiva contro i suoi compagni. Pagina del manuale: mantenere la freddezza, aspettare l’uscita del portiere, flettere il capo a destra per far credere di tirare in quella direzione, scagliare violentemente il pallone verso l’angolo sinistro. Perfetto. Si era ritrovato abbracciato alle maglie della rete, in attesa dell’abbraccio dei propri amici. E al fischio di chiusura correva per il campo, i pugni alti al cielo.